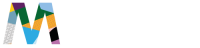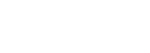Il Castello di NIELLA TANARO – Secoli di storia: tra guerre, fede e rinascita

testo di SEBASTIANO CARRARA
IL CASTELLO DI NIELLA TANARO rappresenta un affascinante esempio di evoluzione storica e architettonica, che riflette le vicende della regione e della sua gente nel corso dei secoli. Dalla sua costruzione come punto di guardia al guado sul fiume Tanaro è testimone di un continuo cambiamento che riflette l’instabilità e la prosperità di questi territori.

Il sito, che conserva ancora tracce significative del suo passato medievale, è un punto d’incontro tra storia, cultura e architettura. La torre quadrata ben conservata, alta circa 20 metri, è il cuore dell’edificio e testimonia l’originale impianto fortificato, mentre le feritoie nelle mura in arenaria offrono uno spunto sulla funzione difensiva.
Il legame tra il maniero e la parrocchiale della Beata Maria Vergine Assunta, con il suo magnifico abside romanico e i lacerti di affreschi gotici al suo interno, suggerisce come la comunità di Niella fosse fortemente legata a questo sito non solo per la difesa, ma anche per la religiosità e la spiritualità del tempo. L’aspetto dell’edificio è oggi quello di una struttura ricettiva, grazie ad un sapiente intervento di restauro appena concluso.

Il castello di Niella è quindi una vera e propria testimonianza storica e architettonica, che unisce passato e presente, e invita alla riflessione sulla continuità e il cambiamento di un territorio che ha visto l’influenza di diverse dominazioni.
Ha una vicenda che risale a un periodo cruciale nella storia medievale del Piemonte. La sua costruzione, probabilmente tra il 1125 e il 1160, si inserisce nel contesto del Marchesato di Ceva, un’area di grande rilevanza politica e strategica a controllo delle vie verso la costa ligure.
Nel 1142, con l’atto di divisione delle terre del marchese Bonifacio, il Castrum Nigella venne incluso proprio nel Marchesato di Ceva, una zona che si estendeva su un ampio territorio tra le valli Casotto e Bormida.
Nel 1295, il Marchesato venne diviso, ceduto ad Asti, infeudando come signori i medesimi marchesi il cui massimo esponente era Giorgio II, soprannominato “il Nano”.

Il passaggio delle truppe napoleoniche attraverso Niella evidenzia il coinvolgimento delle piccole realtà locali nelle grandi dinamiche militari dell’epoca. Come molte altre zone, anche questo Comune fu una tappa della guerra che, tra il 1795 e il 1796, coinvolse i nostri territori.
Il fatto che Napoleone imponga una contribuzione di 12.000 lire a Niella, oltre all’accumulo di viveri e foraggi nelle cappelle, testimonia la pesante pressione che le popolazioni locali subirono, costrette a finanziare o sostenere le forze in conflitto sotto la minaccia di ritorsioni.
Il 30 ottobre 1807, il conte Coardi di Carpeneto vende il castello al proprio mezzadro Andrea Piovano, cedendogli anche tutte le terre di pertinenza. In questa transazione Piovano acquisì anche il mulino situato nel castellaro, oltre a ottenere un banco nobiliare nella vicina chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta.

Questo atto segna una significativa transizione di proprietà, in cui un mezzadro, originariamente lavoratore agricolo sotto la giurisdizione della famiglia Coardi, diventa a sua volta proprietario di terre e beni un tempo sotto il controllo nobiliare. La concessione del banco nobiliare nella chiesa parrocchiale rappresenta anche un riconoscimento sociale, attribuendo a Piovano una posizione privilegiata nella comunità religiosa e locale.
Domenico Piovano, soprannominato “Chin”, emerge come una figura di grande ingegno e spirito imprenditoriale alla fine del 1800. Insieme al fratello Pasquale, si dedicava con passione alla coltivazione delle terre circostanti il castello.
Un esempio del suo ingegno fu la sua idea di migliorare il terreno: per sfruttare meglio le potenzialità agricole, Domenico ideò un metodo per estrarre le pietre dal suolo fino a una profondità di un metro, un lavoro arduo che venne eseguito manualmente su una vasta superficie.

Inoltre, realizzò una cisterna all’interno della torre per raccogliere l’acqua piovana, un’innovativa soluzione che consentiva di irrigare i campi, rendendo il terreno ancora più produttivo. La sua capacità di adattarsi e innovare era esemplare per l’epoca.
Nonostante l’energia e la dedizione che Domenico e Pasquale mostrarono nel lavoro, entrambi rimasero celibi e senza figli. La morte di Pasquale durante la prima Guerra Mondiale, nel gennaio del 1918, segnò una tragedia personale per Domenico, che poi morì nel 1937 a Niella.
Dopo la sua morte, il castello passò nelle mani della sorella Lorenzina, sposata con Giò Matteo Benedetto, un calzolaio di Niella. Questo segnò un altro capitolo nella storia della proprietà del castello.
Viaggio nel tempo: Niella Tanaro com’era

Cosa vedere e cosa fare a Niella Tanaro
- Il Castello. Qui info
- La Confraternita di Sant’Antonio Abate. Qui info
- Parrocchiale di Maria Vergine Assunta e Cappella di Nostra Signora
- Parrocchiale di San Teobaldo
- I murales sulla filiera del pane
- Il forno comunitario
- Il campo sperimentale dedicato alla Nigella e alle Segetali
- Antico insediamento di San Bartolomeo a Valmorej
- Cappella della Natività di Maria a Roà Sottana
- Cappella di San Bernardo a Poggio
- Cappella di Sant’Anna a Sant’Anna
- Cappella di San Pantaleone
- Cappella di San Rocco
Sentiero Landandè a Niella Tanaro: i percorsi
Le feste
- Festa della Nigella maggio-giugno
- La Festa del pane fine agosto
- Festa di San Rocco agosto
La nigella

Niella deve il suo nome a un fiore, raffigurato anche nello stemma del Comune: la nigella, una pianta che un tempo cresceva spontaneamente nei campi di grano, prima che l’agricoltura moderna ne causasse quasi la scomparsa. I semi di nigella conferivano al pane un sapore particolare, e quello prodotto a Niella Tanaro era particolarmente apprezzato. Oggi un’Associazione sta rilanciando la nigella, promuovendone la coltivazione attraverso un apposito disciplinare e incentivando la produzione di un pane speciale e altri prodotti. Per saperne di più clicca qui
Bibliografia di riferimento
- Atlante Castellano. Strutture fortificate della provincia di Cuneo. A cura di Micaela Viglino Davico, Andrea Bruno jr., Enrico Lusso, Gian Giorgio Massara, Francesco Novelli, CELID 2009
- Storia di Mondovì e del monregalese, volume 1 Le origini e il duecento. Rinaldo Comba, Giuseppe Griseri, Giorgio Lombardi, Editore Società per gli studi storici della provincia di Cuneo, 1998
Trova il castello di Niella Tanaro su Google Maps